Diamoci del … lei
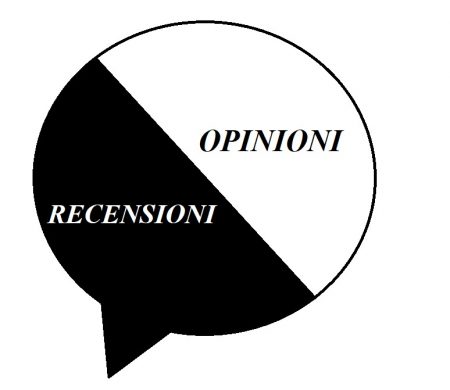
Tempo fa, durante una seduta della Camera dei Deputati, il Presidente, nel dare la parola a una parlamentare, l’ha chiamata “deputata”, secondo il corretto protocollo linguistico; l’interessata ha ribattuto chiedendo di essere nomata “deputato” perché l’Organo di cui fa parte “si chiama Camera dei Deputati e non «Camera dei Deputati e delle Deputate». Non è dato sapere se affermando ciò la parlamentare volesse implicitamente sollecitare una -peraltro auspicabile -modifica nella denominazione dell’Organismo parlamentare, oppure se, come accade non di rado, considerasse riduttivo della sua autorevolezza l’essere appellata al femminile.
Comunque sia, il fatto in sé merita qualche osservazione di ordine generale proprio in riferimento alla seconda opzione interpretativa, che, al di là del fatto specifico, è tutt’altro che peregrina, visto quanto spesso si constata. Nel 1987 la Commissione Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva commissionato e pubblicato “Il sessismo nella lingua italiana”, a cura di Alma Sabatini; nel 1994 l’Unesco aveva sollecitato l’eliminazione dei gap di genere nel linguaggio, e da più di un decennio Cecilia Robustelli arricchisce il pluridecennale dibattito sui riflessi linguistici dei mutamenti socioculturali.
Ciononostante, si avverte ancora una certa riluttanza di fronte alla femminilizzazione di parole indicanti ruoli tradizionalmente rivestiti dagli uomini, soprattutto se si tratta di funzioni apicali: si persiste, infatti, nel considerare il maschile come parametro di riferimento valoriale in ogni “coniugazione” del fare e in ogni “declinazione” dell’essere: “Il principio base è sempre quello che il maschile (genere grammaticale) è superiore, così come lo è il maschile (genere sociale) nella società” (Alma Sabatini, op. cit.). A giustificazione di tale preferenza, si adduce il motivo della cacofonia che grava su alcuni neologismi, non comprendendo che il “gap fonico” è dovuto, da un lato, all’assenza del valore d’uso di quel femminile; dall’altro, a quell’ironia puntuta che accompagna i (peraltro corretti) neologismi, come prefetta, direttora, avvocata, ingegnera, architetta, etc. Non solo: più prestigioso è il ruolo cui le donne arrivano, più sferzante è l’ironia che viene messa in azione per minare l’autostima femminile, come nel caso della nota querelle “ministra/ministressa…”.
La questione, è variamente considerata: alcuni, afflitti da benaltrismo (“sono ben altri i problemi di cui occuparsi…!”) la ritengono irrilevante; altri, ignorano che il linguaggio è “meccanismo di controllo” (così M. Foucault, in “L’ordine del discorso”), ovvero contiene rapporti di forze che dalla dimensione linguistica si trasferiscono nella società, e viceversa. Succede, perciò, che quando nella “grammatica delle parole” si utilizza un maschile che nel genere ingloba il femminile, si ripristina quella “grammatica della vita” cementificata nei tradizionali rapporti uomo –donna in cui la parola empowerment conta come il due di picche nel bridge. Oltretutto, spesso il “femminile invisibile” provoca episodi di una comicità esilarante, come quando, anni fa, una giornalista, per annunciare l’arrivo in Italia di Angela Merkel e dovendo decidere se femminilizzare o no il suo titolo istituzionale (cancelliera o cancelliere ?…), ha optato per un “tradizionale” maschile, col risultato che …“il cancelliere tedesco è arrivato in Italia insieme al marito“…. Per non parlare, poi, di quando “il pretore è stato portato d’urgenza in sala parto perché gli si sono rotte le acque in anticipo…”!
Comunque, con buona pace dei tradizionalisti del dire e del pensare, le inusuali femminilizzazioni di parole tradizionalmente declinate al maschile, sono state accettate anche dall’Accademia della Crusca – il dizionario Treccani ha introdotto recentemente la forma femminile delle professioni – e hanno trovato linfa vitale anche in ambito giornalistico, dove, fin dagli anni Novanta, il femminile “direttora” è stato spesso preferito a “direttrice” (“direttrice ci sembrava una cosa troppo scolastica…”, Neliana Tersigni, La Repubblica” del 26 febbraio 1995). In merito, così osserva l’antropologa Gioia Longo: “Dare un nome è un primo atto d’ identità. Prima non c’erano donne presidenti o segretarie generali di un partito …., quindi non c’era la parola. Oggi, che le donne ci sono, per alcuni continua ad essere difficile usare le parole al femminile….”. Ovviamente, l’aspetto dirimente è dato dall’autoconsapevolezza: nei processi mentali e di comunicazione “le parole presuppongono esperienze condivise. E’ come un sapore o un colore: se l’altro non ha visto quel colore o non ha percepito quel sapore le definizioni sono inutili” (J. L. Borges); e allora, il compito delle donne impegnate nelle Istituzioni è quello di contribuire ad ampliare i “sapori” e i “colori”, secondo i protocolli linguistici e mentali suggeriti fin dal 1995 dalle due parole chiave della Conferenza ONU di Pechino: maintreaming ed empowerment.