L’11 marzo 1818 usciva (anonimo) il romanzo «Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo» in 500 copie. Storia di un mito impossibile creato da una diciannovenne… con nessuna esperienza di scrittura
Vi propongo questo articolo scritto da Maria Paola Saci perché oggi ricorre la storia di un mito impossibile cretato da Mary Wollstonecraft Godwin Shelley
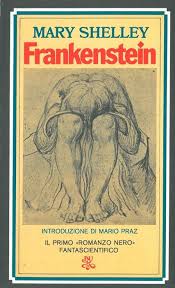
I, the miserable and the abandoned, am an abortion, to be spurned at, and kicked, and trampled on.
Io, l’infelice, lo scacciato, io sono un aborto che si rifiuta, si prende a calci, si calpesta.
«Frankenstein» di Mary Shelley
L’11 marzo 1818 usciva, in tre volumi, presso la casa editrice londinese Lackington, Hughes, Harding, Mayor, and Jones, in 500 copie, un romanzo dal titolo «Frankenstein, ovvero il moderno Prometeo», anonimo. L’anonimia non impedisce alla rivista Tory «Quarterly Review» di avvertire puzza di bruciato e di individuare nell’Anonimo un seguace della “satanica” sètta letteraria che avrebbe fatto capo a Byron, e che includeva anche P. B. Shelley. L’intuito bigotto dei redattori li aveva portati vicino alla verità: l’autore era un’autrice, Mary Wollstonecraft Godwin Shelley (1797-1851). L’uso del grassetto per Wollstonecraft non è un refuso ma un omaggio – l’8 marzo è appena trascorso – a Mary Wollstonecraft (1759-1797), figura chiave del protofemminismo, il cui testo più noto, «A Vindication of the Rights of Woman» (1792), in favore dell’educazione delle donne, resta una pietra miliare su una lunghissima strada che, a volte, ci sembra senza fine. Era la madre dell’autrice. Godwin era il cognome del padre:William Godwin (1756-1836), filosofo illuminista radicale, pedagogista libertario, politico anarcopacifista, scrittore ad ampio spettro, di trattati filosofico-politici-pedagogici, romanzi, libri per ragazzi etc. Shelley era il cognome del marito, Percy Bysshe Shelley non ha bisogno di presentazioni, è l’incarnazione stessa de Romanticismo inglese, fa parte della triade Keats-Byron- Shelley; ammiratore e seguace delle idee di Godwin, nonché suo finanziatore, era fuggito con la figlia Mary nel 1814. Mary l’aveva sposato alla fine del 1816. “ Che ragazza fortunata!” direte voi. Qui finiscono le buone notizie
Ora le cattive. La madre era morta di setticemia da parto- da sempre principale causa di morte per le donne (vedi J. F.Céline, Il dottor Semmelweis, 1924) – dieci giorni dopo averla data alla luce; il padre, come tutti i pedagogisti illuminati (vedi Rousseau, l’ autore dell’Emile che, forse, aveva abbandonato ben cinque figli all’orfanatrofio… forse) era incapace di occuparsi dei figli – figuriamoci se femmine – coperto di debiti e risposato con una piccolo borghese rancorosa, già madre di due figli, alquanto matrigna verso Mary e l’altra figlia della Wollstonecraft, Fanny Imlay, che Godwin aveva adottato; il matrimonio con Shelley era stato possibile solo perché la giovane prima moglie del poeta, dalla quale aveva avuto due figli, si era suicidata. Dalla fuga in Francia del 1814 in poi la vita della giovanissima Mary era divenuta una drammatica, ed eminentemente romantica, ronde di amore e morte: nascite, lunghi viaggi, eccitanti ma troppo faticosi, miseria, aborti, due figli morti in fasce, il suicidio della moglie di Shelley ma anche quello della sorellastra Fanny, avevano funestato l’esistenza dei due giovani innamorati.
Comunque nella gelida estate del 1816 – l’anno senza estate a causa dell’eruzione del vulcano Tamboro – Mary e Shelley sono in Svizzera, in una casa nel distretto di Belle Rive; nella vicina villa Diodati soggiornano Byron e il suo medico, John Polidori. Fa freddo e la sera si ritrovano tutti insieme a leggere e tradurre romanzi dell’orrore, a parlare di galvinismo e degli esperimenti di Erasmus Darwin- sì, il nonno di Charles- per far rivivere i vermi (sic). Per ingannare la noia Byron lancia un’idea: ciascuno di loro quattro dovrà scrivere un racconto dell’orrore. Shelley, Byron e Polidori verranno meno alla promessa e, spiace dirlo, moriranno tutti nel giro di pochi anni; solo Mary, grazie a un incubo, darà alla luce la storia, archetipica e imperitura, del Mostro-senza-nome che tutti chiamano Frankenstein. Aveva diciannove anni, nessuna esperienza di scrittura, e aveva creato un mito. Come fu possibile?
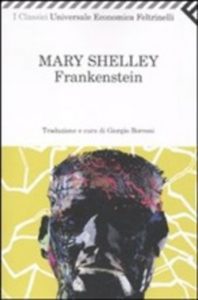
“Did I request thee, Maker, from my clay
To mould me man? Did I solicit thee
From darkness to promote me?”
Ti ho chiesto io, Creatore, di farmi uomo
dalla mia argilla? Ti ho pregato io
di farmi uscire dalle tenebre?
«Paradise Lost» di John Milton
La risposta non la so. Propongo di scomporre un po’ il Mostro per provare a capirci qualcosa. Tanto il poveretto ci è abituato: nasce come assemblaggio di pezzi di cadavere. Mary aveva avuto un’educazione disordinata, ma ricca e moderna; aveva conosciuto lunghi periodi di abbandono in un’infanzia spesso solitaria, ospite di una famiglia amica nelle fredde e desolate solitudini della Scozia e aveva partecipato alle dotte conversazioni nella casa del padre; sapeva di filosofia, di letteratura e un po’ di scienze ma, soprattutto, aveva sperimentato, come bambina e come madre adolescente cresciuta troppo in fretta, che gli uomini, padri per caso, in assenza di madri, rendono i figli, sempre, necessariamente, orfani. Questa è la sua esperienza. Questa è la maledizione del Mostro, il quale addirittura non è un nato di donna. E’ il frutto di un esperimento scientifico, della megalomania di un giovane scienziato che vuole generarsi un figlio da solo, negando il bisogno dell’Altra, del femminile. Frankenstein, spinto dall’amore per la scienza (o dal terrore verso le donne) è l’uomo che vuole farsi Dio; ma no, Dio ebbe pietà di suo figlio fatto uomo e non lo abbandonò senza madre tra gli uomini. Lui, invece, pensa di poter provvedere raccattando cadaveri e affidandosi alla galvanizzazione.
Molti critici hanno sottolineato l’attualità del romanzo interpretandolo come una sorta riflessione bioetica ante litteram sui danni della scienza allorché pretende di manipolare i “sacri misteri” della vita. Ma di questa condanna c’è scarsa traccia nel romanzo; la parte “scientifica” del processo di creazione è, ovviamente, molto generica e anche la riflessione sulla legittimità della manipolazione è appena accennata. Il grande scienziato non aspetta neppure un minuto per decretare che il suo esperimento è fallito e rifiutarne il frutto: guarda l’enorme, adulto “neonato” che ha prodotto, lo trova assai brutto, discordante con il tipo ideale che aveva in mente, gli ripugna, fugge e lo abbandona al suo destino senza neppure un nome. Non sembra una reazione molto scientifica, tanto più che, in fondo, l’esperimento aveva funzionato: il Mostro non era tanto bello – beh, che si può pretendere quando si crea una vita con pezzi di morte?- ma era animato dai migliori sentimenti, come è ampiamente illustrato nella prima parte del racconto. Abbandonato a se stesso, senza alcuna esperienza degli uomini e della vita, senza una guida, vive nascosto nei boschi; pure evidenzia immediatamente uno spiccato gusto preromantico per i paesaggi sublimi, si butta a leggere Milton, Goethe e Plutarco con commozione e interesse; filantropico, aiuta di nascosto una povera e saggia famiglia. Sarebbe, dunque, l’ incarnazione perfetta del buon selvaggio, l’uomo puro nello stato di natura. Un novello Adamo che impara a nominare tutto il mondo da capo. Ma qualcosa va storto, come sempre nell’Eden. Il poveretto vorrebbe gustare il frutto della gratitudine, vorrebbe essere amato da coloro che ha aiutato, ora che ha conosciuto l’amore osservando la bella famigliola. Si presenta perciò al vecchio pater familias per mettersi sotto la sua protezione; quello, essendo cieco e benevolo, lo accoglie ma poi arrivano i giovani, che ci vedono benissimo e il sogno d’amore s’infrange. Il suo aspetto suscita orrore, le fanciulle svengono, il giovane uomo gli si scaglia contro. Fugge: non c’è posto per lui tra il genere umano, non ne fa parte. Fugge e dà inizio alla catena di efferati delitti. E’ il fallimento dell’educazione illuminista.

E’ dunque questo il tema del romanzo, il rifiuto del diverso? Sì, questo tema percorre la storia, come un problema mai risolto; l’autrice non riesce a stare dalla parte del Mostro pur se sentiamo vibrare nelle sue parole una profonda identificazione con l’infanzia del personaggio, ci sembra che stia sempre per gridare : “Il mostro sono io!”. Ma non lo scrive. Il titanico Victor – c’è un’antifrasi, un’ironia, in questo nome parlante? – Frankenstein, prima buon figlio, giovane sentimentale innamorato di un’ angelica sorellastra adottiva (quante sorellastre, tutt’altro che angeliche, aveva avuto Mary!); poi bello e dannato, divorato dall’ansia di portare a termine il suo esperimento; infine, ormai solo anche lui, vittima rabbiosa della vendetta del Mostro, impegnato in una caccia tragica alla sua “creazione” che gli ha sterminato ogni affetto, finisce per imporsi alla sua Autrice, le viene meno il coraggio di confessare che solo lui, con il suo spensierato e tronfio egotismo maschile, è la causa di tutto, che da una generazione aberrante non possono derivare che lutti, che il Mostro, in fondo, non è che un povero orfano gettato nel mondo da un padre maldestro.
E’ un limite questo? Sì e no. La capacità mitopoietica del Moderno Prometeo nasce proprio da questa oscillazione di simpatie, che fa sì che «Frankenstein» non sia mai un romanzo a tesi, un conte philosophique sulla sconfitta dell’Illuminismo, sui limiti etici delle scoperte scientifiche, né un romanzo edificante sull’infanzia abbandonata o sull’iniquità di ogni razzismo.
E’, invece, una storia di ragioni e sentimenti, sul nascere e crescere su questa terra, bella e desolata, sull’essere donna o essere uomo, essere madri ed essere figli, amati e rifiutati. Una storia infinita, sempre aperta. Una storia horror, ecco.
Da L Bottega del barbieri – il Blog di Daniele Barbieri & altr*-


